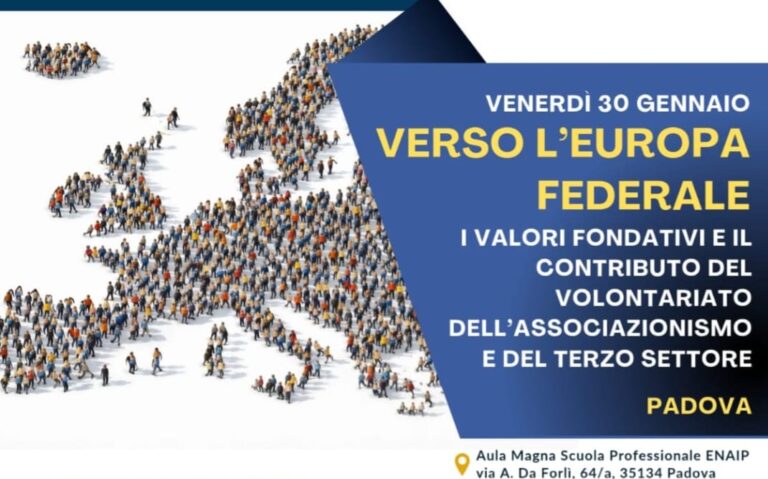Franco: “Il giornalismo ha il dovere di lavorare per la pace”
di Giulia Alberoni
TREVISO – In tempi in cui la guerra non è solo un evento lontano, ma un flusso costante sugli schermi di qualsiasi device, dalla tv allo smartphone, è impossibile non chiedersi come la si debba raccontare ai nostri tempi e, rispetto a qualche anno fa, come è cambiato il lavoro dei giornalisti che vivono direttamente in prima linea i drammi che essa comporta.
Per provare a rispondere a queste ed altre domande, ci siamo affidati a chi queste trasformazioni le ha vissute sulla sua pelle.
Pierluigi Franco, giornalista di lungo corso, ha attraversato i grandi scenari di crisi internazionale degli ultimi quarant’anni: dall’Iran, dove è stato l’ultimo giornalista occidentale a lavorare stabilmente, dai Balcani al Medio Oriente. Per anni corrispondente dell’ANSA, capo del servizio ANSAmed e ideatore di ANSA Nuova Europa, Franco è un profondo conoscitore dell’Europa orientale, e testimone diretto di un tempo in cui l’informazione bellica si costruiva con fatica e con responsabilità.
Oggi, in un’epoca dominata dalla comunicazione istantanea e dalla sovrapposizione di voci, immagini e interessi, il giornalismo di guerra ha assunto nuove forme – e nuove fragilità. Con lui abbiamo parlato di come sia cambiato il racconto dei conflitti, del ruolo del giornalista come testimone, e della possibilità che l’informazione contribuisca ancora, in qualche modo, alla costruzione della pace.
Prima di tutto, quando ha capito di voler diventare giornalista e quale è stato il suo percorso?
Ho iniziato facendo la classica gavetta. La mia prima collaborazione è stata con Il Messaggero, a livello locale. Mi piaceva l’idea di questo lavoro, anche se avevo iniziato anche la carriera da avvocato. Ma era chiaro che ciò che mi appassionava davvero era il giornalismo, che poi è rimasto la mia grande passione. Piano piano sono poi diventato professionista.
Guardando all’indietro la sua carriera, c’è un momento particolare che ha rappresentato una svolta, sia umana che professionale, un pivot point?
Ce ne sono tanti, in realtà. Tante esperienze stimolanti che mi vengono in mente, non sarei in grado di sceglierne una sola.
Una delle sue esperienze è stata la corrispondenza in Iran. Com’è stato essere testimone diretto in quel contesto?
Era una congiuntura temporale favorevole, il periodo dell’accordo sul nucleare. Sembrava che l’Iran potesse aprirsi al mondo occidentale. Conobbi personalmente personaggi come il presidente Rouhani e il ministro degli esteri Zarif, entrambi riformisti, di formazione occidentale. Era un momento in cui si intravedeva una possibile svolta positiva. Ma forse l’Occidente non ha saputo capire appieno quell’opportunità.
La domanda che mi sorge spontanea riguarda la raccolta delle fonti, anche come essa è cambiata nel corso del tempo. Come si informava lei sul campo, prima e dopo l’avvento dei social media?
Avevo una visione diretta, avevo la possibilità di assistere a conferenze stampa, di frequentare i ministeri, parlare con le fonti. E poi c’era un’ottima rete di collaboratori sul campo. La realtà si poteva tastare tutti i giorni. Il tema dei social è un discorso curioso: sono uno di quelli che crede che il giornalismo abbia iniziato a morire nel momento in cui ha cominciato ad attingere dai social. Lo si vede nel momento in cui bisogna dare una notizia, perché, da quando il ministro interagisce con il popolo direttamente online, il ministro non lo posso più contestare come si faceva una volta. Questa secondo me è una grossa limitazione alla libertà, ma ormai il dado è tratto. Anche quando stavo in Iran la guida suprema scriveva sull’allora Twitter, c’era ogni giorno una sorpresa. Poi è arrivata la prima presidenza Trump e inevitabilmente dovevi seguire i dibattiti sui social, anche se, ripeto, io l’ho sempre fatto a malincuore, perché quando avevo cominciato a fare questo mestiere, lo facevo parlando con l’interlocutore, con chi si occupava di un tema in questione.
Mentre parlava non ho potuto non pensare al ruolo del giornalista in un Paese come l’Iran. In un contesto simile il giornalista come veniva visto: come un appoggio o come un rivale?
In Iran ero sotto controllo. E lo facevano capire. Dagli uomini che venivano a controllare il computer con la scusa di essere tecnici, ai “fiorellini” che apparivano occasionalmente durante le ricerche online. Facevo attenzione, ma di fatto da parte mia non c’era nulla da nascondere.
E oggi, se dovesse scegliere un Paese su cui concentrare il suo sguardo da giornalista, quale sarebbe?
Ce ne sarebbero tanti… sicuramente la Turchia che viene molto sottovalutata. E poi c’è la terribile confusione che domina anche l’Europa stessa. È un tema che ho trattato nel mio prossimo libro, talvolta anche molto critico, in uscita tra maggio e giugno, dal titolo “Cosa resta dell’Europa”. È un volume in cui ho preso in esame la struttura dell’Europa, quello che sta facendo, i danni che si stanno insinuando.
Avrei un altro paio di curiosità: in un lavoro come il suo, svolto in contesti di conflitto, è facile – o utile – mantenere un certo distacco emotivo?
Rimanere distaccato è fondamentale nel giornalismo anche se ciò in questo momento non sta assolutamente avvenendo nel mondo dell’informazione. Soprattutto in questo periodo di guerra si sta andando fortemente indietro nel campo dell’informazione. Non parlerei di emotività, più che altro parlerei di attenzione: non bisogna lasciarsi condizionare dall’emotività o cose di questo tipo che, anche grazie all’età e ai contesti, non intervengono. Penso all’arresto recente di Cecilia Sala, che è seguito a un precedente fermo italiano: la realtà è che ogni movimento deve essere osservato, soprattutto quando si è giornalisti.
Le chiedo a questo punto se la principale differenza tra quando lei ha iniziato, e il contesto attuale, è proprio l’utilizzo dei social di cui parlavamo prima. Questo fatto che c’è una costante e onnipresente informazione diretta, ha fatto perdere al giornalista il suo ruolo di “filtro” in qualità di garante della verità?
Più che un “filtro”, il giornalista dovrebbe essere un “media”, un tramite tra fonte e pubblico. Ho lavorato in ANSA, dove la regola, l’obbligo, era: una prima verifica, una seconda verifica, e possibilmente la terza verifica. Solo allora si pubblicava, perché la notizia doveva essere vera, pura e verificata. Quando si ha la certezza assoluta, si dà la notizia, ma se permane un dubbio la notizia non si dà. È chiaro che se adesso prendiamo in analisi tutti i social, non possiamo fare nessuna verifica, l’unica cosa che possiamo fare è riferire la fonte. È un limite. Si parla di bombardamenti, vittime, dichiarazioni, ma chi li ha visti? Nessuno va a controllare i buchi delle bombe. Il problema è che, anche se non siamo un Paese belligerante, l’informazione si comporta come se lo fossimo.
E l’uso sempre più frequente di immagini crude? È sintomo di libertà o, al contrario, di un problema?
Con quello che può fare oggi l’intelligenza artificiale, non abbiamo più certezze. Io non credo più a niente. Già prima c’erano falsificazioni, come avvenuto nella guerra in Jugoslavia. Mostrare la sofferenza, la disperazione, puo’ essere importante, ma non bisogna cadere nella logica del cruento spettacolo del dolore.
L’ultima cosa che le chiedo, e che vuole essere un ponte con il tema della nostra fondazione, quello della Pace, è se il giornalismo possa ancora avere un ruolo nel promuovere la pace, o se sia solo un racconto nudo della cronaca dei conflitti?
Il giornalista vero ha il dovere di lavorare per la pace. Il dovere. Dovrebbe esserlo sempre. Ma oggi sembra che questo compito sia stato messo in secondo piano. Il giornalismo si è piegato a chi decide. In Europa c’è una pressione bellicista evidente, ripresa sistematicamente dagli organi di informazione. Gli interessi pesano su tutto: prima sulla politica, poi sull’informazione.
È triste doverlo ammettere, ma è preoccupante.