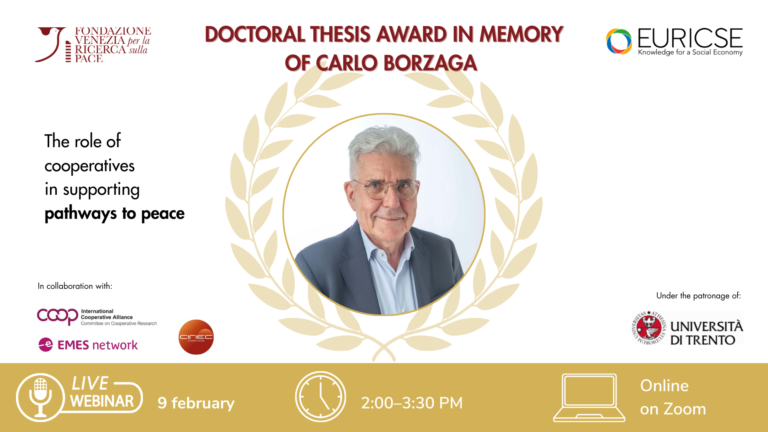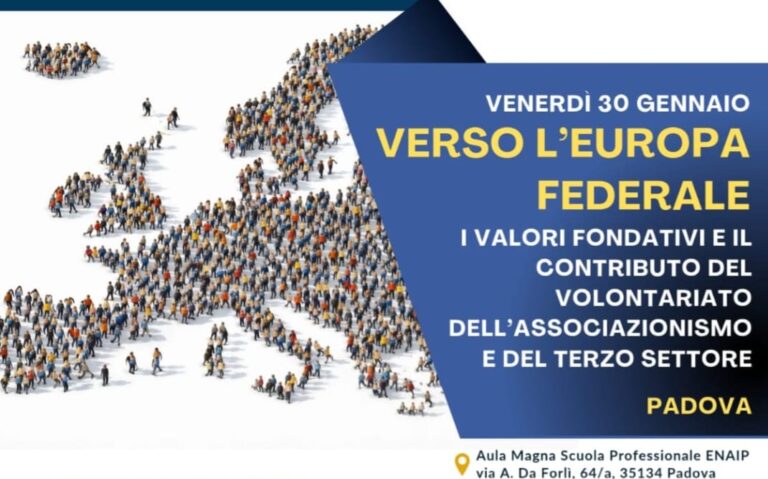La resistenza femminile tra cura, relazioni e ribellione
Si sono svolte venerdì 24 e sabato 25 ottobre a Vittorio Veneto presso il Museo della Battaglia le giornate evento “Demos: le donne che resistono. Gli occhi, le parole e le azioni nella città in fiamme”. Organizzata da “Classici Contro”, un’iniziativa nata presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e presieduta dai Professori Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani, questa serie di incontri incarnano appieno lo spirito dell’iniziativa, che con il tema “Demos” quest’anno si è posta come obiettivo quello di ragionare in un laboratorio aperto di idee su che cosa significhi demos, popolo, negli ultimi tremila anni. Partendo dall’Iliade di Omero e arrivando ai giorni nostri, giovani liceali e universitari hanno riflettuto sul demos come libertà, partecipazione e resistenza tra pace e guerra, temi particolarmente importanti in questo ottantesimo anniversario della Liberazione.

Anche in quest’occasione Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace ha avuto il piacere di partecipare, con il Presidente Antonio Silvio Calò che ha introdotto e moderato la prima sessione di incontri. Durante la mattinata di venerdì il dibattito si è concentrato in particolare sulla figura della donna ed il ruolo che ha avuto nei conflitti che si sono susseguiti nella nostra storia, tracciando parallelismi e intessendo trame che intrecciano emancipazioni incompiute, silenzi e relazioni sociali che si ramificano anche nella desertificazione della guerra.
Questi temi sono evidenti nell’intervento di Silvia Bigai (Aletheia Ca’ Foscari) “La pace secondo le donne di Omero”, che vede riflessa nella condizione delle donne dell’Iliade la condizione delle rifugiate ucraine: mentre gli uomini rimangono a combattere, le donne ed i bambini aspettano o fuggono, indifesi. La figura della donna quindi spesso rappresenta un ossimoro rispetto al contesto di guerra in cui è inserita, dato che nell’attesa o nella distanza porta avanti tutta una serie di attività quotidiane che garantiscono il mantenimento di una minima continuità con un lontano periodo di pace, nonostante tutto in realtà sia cambiato.

L’altra faccia della medaglia, però, non è meno rilevante. Questo è quello che emerge dagli interventi di Margherita Fuga, Giorgia Minto e Sharon Bilotta e dall’introduzione del Professor Alessandro Casellato. Infatti, sebbene durante la seconda guerra mondiale la resistenza delle donne sia stata affine al ruolo tradizionale di cura e “maternage”– il Professor Casellato in particolare ne evidenzia la funzione cardine in una società civile che supporta e garantisce il sostentamento dei partigiani – non si può negare che l’8 settembre 1943 abbia rappresentato per le donne dell’epoca una forma di liberazione sui generis, di riscoperta del proprio agire individuale e della propria facoltà di scelta, fosse questa esercitata in funzione di cura o in funzione di resistenza armata.
Incentivando al pensiero, al rovesciamento delle credenze e degli stereotipi, queste due giornate evento hanno quindi portato alla luce una nuova dimensione della figura femminile fra pace e guerra, una nuova interpretazione dei suoi processi di emancipazione nel dopoguerra italiano. Per la donna, infatti, la fine della guerra non è una liberazione completa: lo è in termini militari e politici, ma non lo è in termini sociali e culturali. La facoltà di scelta, scoperta momentaneamente dopo l’8 settembre 1943, sarà infatti ritrovata solo 30 anni dopo con l’ascesa dei movimenti femministi e la rivendicazione di una serie di diritti quali il divorzio e l’aborto, riprendendo così un processo di emancipazione sociale che dopo il ‘45 era rimasto incompiuto.
Elena Fecchio