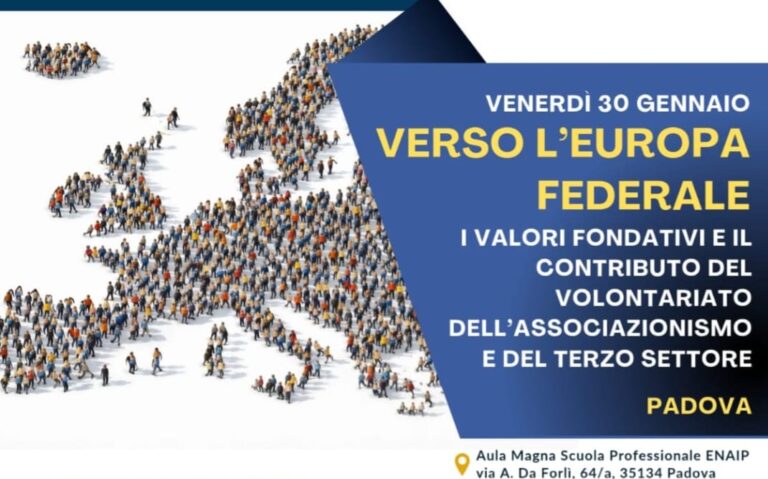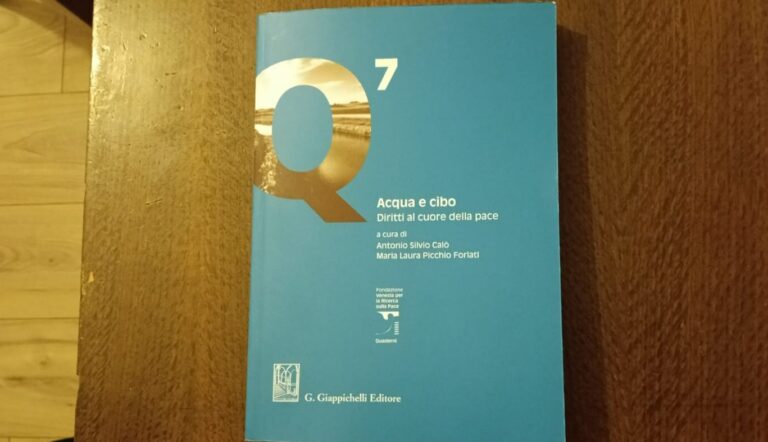L’ecologia del conflitto: rigenerare le relazioni
Disarmarsi, ascoltarsi, differenze, degenerazione, umano, dolore, noi, soglia, essere preziosi, investire. Queste le parole usate dal prof Luca Roti per raccontare Rondine Cittadella della Pace durante il primo appuntamento della seconda edizione della Rassegna di Ponti di Pace, dal titolo “L’ecologia del conflitto: rigenerare le relazioni”, tenutosi il 16 ottobre 2025 presso il Centro Culturale Candiani di Mestre.
L’incontro, organizzato dalla Fondazione Venezia per la Ricerca sulla Pace e Istituto di Studi Ecumenici “S. Bernardino”, vuole portarci a riflettere e conoscere in modo più profondo la realtà e il metodo Rondine, studiato da sociologi di tutto il mondo.
Rondine è un’organizzazione, in un borgo medievale della Toscana, con l’obiettivo di costruire relazioni nuove tra studenti provenienti da paesi bellici e postbellici e riparare i “ponti” che sono stati distrutti tramite la condivisione di storie e vissuti diversi.
Su questo si basa il metodo Rondine, un percorso di convivenza in cui il conflitto, di qualsiasi entità, diventa una risorsa da orientare al bene in cui si comprende che per ottenere la pace “bisogna cambiare sé e ciò che si ha intorno”.
Nasce negli anni Novanta grazie a Franco Vaccari e il gruppo dei fondatori di Rondine che, accumunati dai valori di ospitalità e dialogo, riescono ad aprire una relazione con Gorbačëva, first lady sovietica, favorendo così un canale di comunicazione con l’Unione Sovietica. Nel 1995 Rondine viene chiamata da Mosca per gestire la tregua tra la Cecenia e la Russia, ottenendo un cessate al fuoco della durata di 72 ore che però fallisce.
Al termine del primo conflitto in Cecenia, il rettore dell’Università di Groznyj, Mukadi Izrailov, chiede a Rondine di poter ospitare i ragazzi che non sono riusciti a completare gli studi a causa del conflitto. L’organizzazione ha accettato di ospitare gli studenti ceceni a patto che volessero convivere con studenti russi. Nasce così lo Studentato Internazionale che concretizza la visione di Rondine: un luogo in cui i ragazzi, convivendo con i loro “nemici”, diventano dei leader; non sotto il punto di vista politico ma come una persona che sa gestire le relazioni che ha intorno a sé.
Importantissima le testimonianze portate da due ex-studenti di Rondine: Issan e Sharizan Shinkuba che hanno raccontato la loro storia e quella dell’organizzazione, con i suoi innumerevoli successi e anche “fallimenti”, e i motivi che li hanno spinti a candidarsi come studenti a Rondine e come essa funziona.
Sharizan Shinkuba è una ragazza della Abcasia, una regione nel Sud Caucaso non riconosciuta come paese a livello globale, che lavora a Rondine come formatrice del metodo Rondine. Il suo paese ha dovuto affrontare una guerra ideologica e territoriale con la Georgia; la guerra si conclude con la vittoria abcasa e l’indipendenza della regione. Anche se di fatto la guerra si è conclusa, lei si è sempre domandata se effettivamente fosse realmente finita e cosa significava realmente aver vinto e odiare i georgiani. Il suo voler trovare delle risposte la porta a Rondine, dove ha avuto l’occasione di trovare una risposta e l’opportunità di farsene altre in quanto l’esperienza ti offre una nuova prospettiva sulla vita ma soprattutto sul conflitto.
Issan è un ragazzo palestinese, studente di Rondine, che dopo aver finito il suo percorso a ha cercato lavoro in Palestina e anche in Italia. Dopo aver trovato lavoro in Italia, continua a cercare lavoro nella sua terra ma lo scoppio della guerra non gli ha permesso di tornare. Dopo un po’ di tempo torna a Rondine, che gli offre un lavoro come analista dati. Spiegando all’assemblea come Rondine seleziona i propri studenti, fa luce su una problematica molto importante per il suo funzionamento: i ragazzi che non credono nel progetto e vanno lì per i loro interessi.
Durante l’evento, inoltre, è stata fornita un’immagine meravigliosa che descrive e spiega Rondine, il titolo dell’evento e la simbologia dei “Ponti di Pace”: se immaginassimo due persone davanti a un tavolo che avessero il coraggio di disarmarsi delle loro armi e le poggiassero lì, su quel tavolo, e si raccontassero e ascoltassero, allora si innamorerebbero l’uno dell’altro e ci si avvicinerebbe alla pace. La simbologia del ponte invoglia noi tutti a riporre le nostre “armi” e lentamente percorrere la strada insieme per raggiungere e promuovere una pace: reale, concreta, tangibile, duratura e definitiva.
Adriana Randazzo