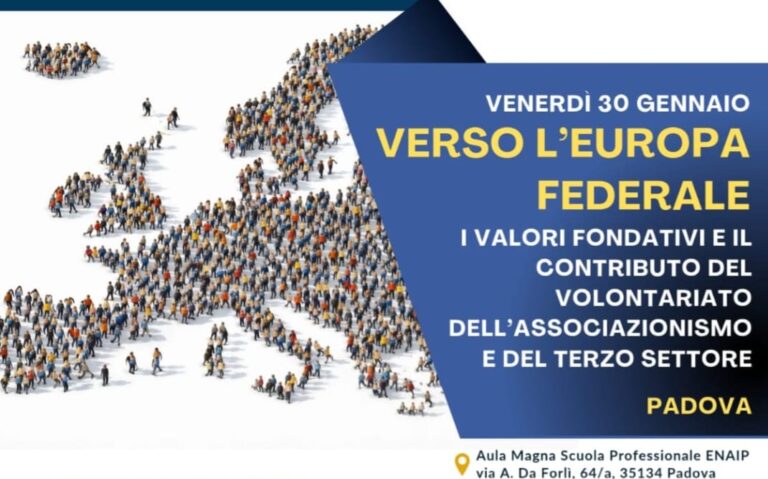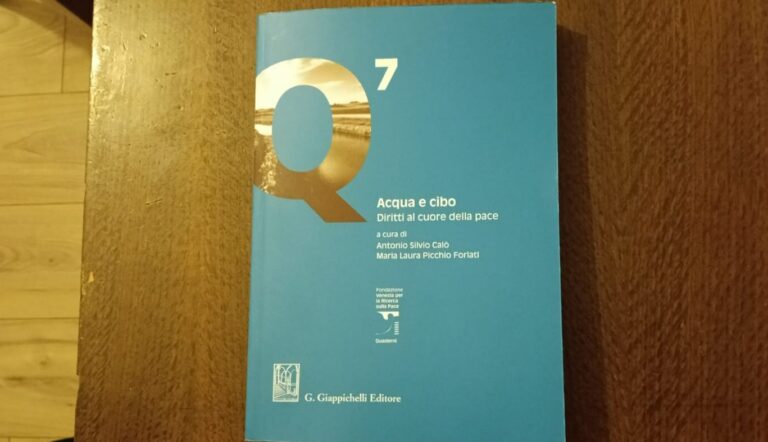Il cambiamento climatico in Africa: una realtà quotidiana di comunità
In questa puntata della rubrica Mappamondo, ci spostiamo in Africa, per la precisione in Zimbabwe. Nell’articolo che presenteremo, tratto dall’edizione del 3 novembre del The Herald e in origine pubblicato da The Conversation, Decide Mabumbo parla di come per molte comunità africane il cambiamento climatico non sia uno scenario futuro più o meno probabile, ma il presente.
Basandosi sulla sua esperienza di ricercatore presso l’International Water Management Institute – una non-profit che si occupa di mettere a punto sistemi di gestione di acqua e terreni che possano favorire la sicurezza alimentare, il sostentamento e la resilienza climatica – Mabumbo esorta il Sudafrica, a cui spetta la presidenza del prossimo G20, ad utilizzare questo forum internazionale per porre l’accento su quanto sia importante investire su coltivazioni resistenti alla siccità e su sistemi di irrigazione e di gestione dell’acqua ideati in base ai bisogni e alle pratiche delle singole comunità.
Sono quattro le aree che beneficerebbero particolarmente della presidenza sudafricana del G20 2025: capacità di archiviazione di dati relativi ai fenomeni climatici a livello continentale ed efficacia dei sistemi di monitoraggio; empowerment di comunità ed esperti locali nella pianificazione e nella gestione di questi sistemi; costruzione di infrastrutture resistenti ai disastri naturali; finanziamento di sistemi e tecniche di prevenzione.
Infatti, investire in metodi di raccolta ed analisi di dati relativi all’andamento delle piogge e al livello dei corsi d’acqua può portare ad un significativo miglioramento dei sistemi di monitoraggio, che con un allarme emesso anche solo 24 ore prima di un eventuale disastro naturale possono ridurre i danni del 30%. Un altro passo che Mabumbo vede come fondamentale è coinvolgere le conoscenze e le competenze locali ideando strumenti che le possano sfruttare al meglio. Per esempio, l’articolo parla di un progetto che ha creato piattaforme di prevenzione utilizzando mezzi digitali accessibili a tutti (smartphones, computer portatili, ecc.): integrando dati satellitari, previsioni meteorologiche, pratiche e conoscenze locali, queste piattaforme sono un aiuto fondamentale per autorità comunali e privati cittadini che si preparano all’impatto di un potenziale disastro.
Tutte queste azioni, però, devono essere incentrate su due principi: costruire meglio – non semplicemente di più – e prevenire piuttosto che curare. I fondi su base meteorologica in Bangladesh, per esempio, incarnano perfettamente questi due principi: invece che aspettare di dover impiegare ingenti risorse in chiave post-emergenziale, le risorse vengono sbloccate prima che le alluvioni, fenomeno a cui il Paese è particolarmente esposto, colpiscano le zone più a rischio. Un altro modo per facilitare queste azioni di prevenzione è progettare strade che siano in grado di resistere alle alluvioni, per esempio, oppure dotarsi di sistemi di drenaggio nel caso di forti piogge e unire soluzioni ingegneristiche a soluzioni basate sulla natura stessa. Tali soluzioni includono risanare le paludi per assorbire le acque alluvionali e incorporare una grande quantità di verde nelle aree urbane, rendendole più fresche anche in caso di temperature estreme.
In conclusione, le quattro aree di azione individuate da Mabumbo sembrano delineare il bisogno di rivedere la nostra concezione di disastro naturale come un fenomeno di natura globale – invece che puramente casuale – che è capace di colpire ogni categoria, ogni località e che necessita di una risposta collettiva, che coinvolga l’intero spettro dell’amministrazione pubblica.