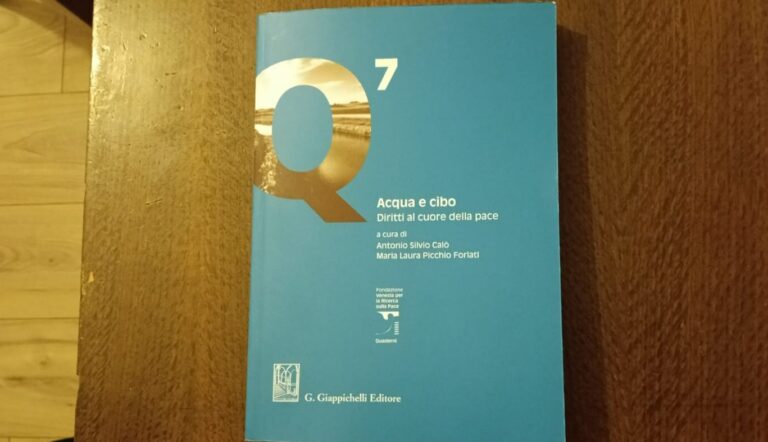Regno Unito, Germania e Giordania denunciano atrocità in Sudan e chiedono un cessate il fuoco immediato
In questo appuntamento della rubrica Mappamondo, commenteremo l’articolo del giornalista Malek Fouda, pubblicato da EuroNews l’1 novembre 2025.
La denuncia congiunta di Regno Unito, Germania e Giordania sulle atrocità in Sudan – emessa in occasione del Manama Dialogue 2025, organizzato dall’Institute for International Strategic Studies (IISS) l’1 novembre in Bahrain – riporta al centro dell’agenda internazionale una guerra che, pur avendo già provocato migliaia di morti e milioni di sfollati, è rimasta ai margini dell’attenzione globale. In un paesaggio geopolitico segnato da crisi simultanee, competizione tra potenze e priorità diplomatiche sempre più frammentate, l’appello dei tre ministri degli Esteri si colloca in una fase critica del conflitto sudanese, dove la violenza sembra aver raggiunto una nuova soglia e la capacità internazionale di risposta appare limitata.
Le prove emerse da al-Fasher — esecuzioni sommarie, violenze sessuali sistematiche, attacchi contro civili e strutture sanitarie — hanno alimentato accuse di crimini di guerra e, secondo alcuni osservatori, di genocidio. L’argomentazione dei governi europei e mediorientali si fonda sull’idea che la Rapid Support Forces (RSF) stia conducendo operazioni mirate a consolidare un controllo territoriale attraverso il terrore. Una narrativa che intreccia allerta umanitaria, pressing diplomatico e posizione morale. Tuttavia, la comunità internazionale non ha ancora definito un quadro d’azione concreto per interrompere le ostilità o garantire corridoi umanitari sicuri.
Di fronte a questa situazione, l’arena strategica globale si divide. Da un lato, chi ritiene che la condanna pubblica e la richiesta di un cessate il fuoco possano contribuire a isolare politicamente i comandanti delle RSF e rafforzare la pressione multilaterale verso una soluzione negoziata. Dall’altro, chi teme che la risposta diplomatica — priva di strumenti coercitivi immediati — rischi di risultare insufficiente, lasciando campo libero a una dinamica di violenza già fuori controllo. La storia recente di interventi mancati e di crisi umanitarie protratte alimenta lo scetticismo.
Sul piano operativo, le agenzie umanitarie sostengono che l’accesso agli aiuti sia progressivamente compromesso e che, in molte regioni, le infrastrutture civili siano al collasso. La capacità di risposta internazionale è indebolita sia da vincoli logistici sia da un sistema multilaterale sovraccarico, impegnato in più teatri di crisi contemporaneamente. In Sudan, dunque, la sfida non riguarda solo l’imposizione di un cessate il fuoco, ma la possibilità di impedire che il tessuto sociale si disintegri definitivamente, mentre la carestia e le epidemie si diffondono.
La dimensione geopolitica della crisi non è secondaria. La rivalità tra attori regionali e il coinvolgimento indiretto di potenze esterne — interessate alle risorse sudanesi e ai corridoi strategici che attraversano il Paese — complicano ulteriormente lo scenario. In questo contesto, le milizie della RSF si muovono con una logica paramilitare fluida, combinando reti economiche, sostegni transnazionali e controllo territoriale. Ogni passo diplomatico deve quindi confrontarsi con una realtà sul terreno che sfida i meccanismi tradizionali di mediazione e contenimento.
Resta il fattore politico interno ai Paesi che condannano. Le dichiarazioni di Londra, Berlino e Amman riflettono tanto un imperativo morale quanto una necessità strategica: riaffermare un ordine internazionale che si percepisce sempre più vulnerabile. Un messaggio rivolto non solo ai leader sudanesi, ma anche ai rivali globali e ai cittadini che guardano con crescente inquietudine alla capacità delle istituzioni internazionali di prevenire catastrofi annunciate.
L’equilibrio che ne emerge è fragile. La crisi sudanese si colloca in un mondo multipolare privo di architetture robuste di gestione dei conflitti, dove la diplomazia collettiva deve confrontarsi con attori armati non statali, Stati frammentati e flussi umanitari senza precedenti. Non è solo una tragedia locale, ma un test più ampio sulla tenuta del sistema internazionale.
Si potrebbe sostenere che il richiamo alla responsabilità e al cessate il fuoco rientri nella ritualità diplomatica, più che in un piano operativo concreto. Ma, come spesso accade nelle crisi prolungate, la retorica non è neutra. Ogni dichiarazione contribuisce a definire l’orizzonte politico in cui si deciderà se intervenire, come intervenire e — soprattutto — se prevenire un collasso definitivo dell’ordine civile sudanese.
Non ci troviamo davanti a un improvviso precipitare degli eventi, ma a un lento scivolamento verso una tragedia annunciata. Gli elementi — violenza sistemica, paralisi internazionale, instabilità regionale — sono già tutti presenti. Il rischio non è solo la continuazione del conflitto, ma l’erosione progressiva delle capacità collettive di evitarne la normalizzazione. È su questo terreno che oggi si misura la reattività del sistema globale, e su cui si deciderà se il Sudan resterà un capitolo doloroso e isolato o diventerà un precedente che segna un ulteriore cedimento dell’ordine internazionale.